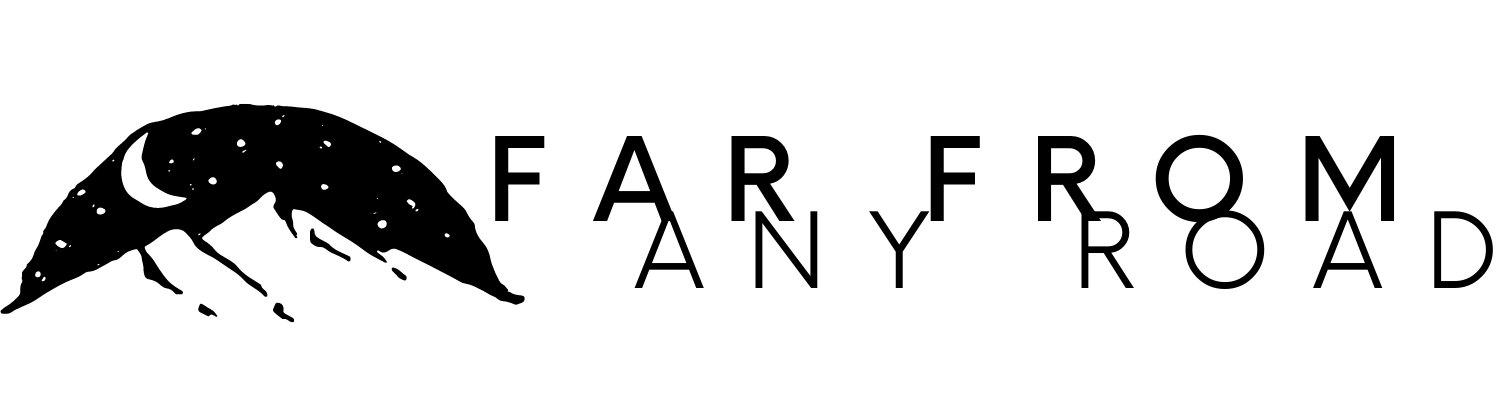Deserto del Mojave: l’ombra incombe sulla sera polverosa
Quando l’ultima luce riscalda le pietre e il serpente si disvela
i puma verranno a trascinare via le tue ossa.
Allora sorgi con me per sempre attraverso la sabbia silente
E le stelle saranno i tuoi occhi e il vento sarà le mie mani
Baker è calda come una dannata fornace: nonostante sia aprile il termometro sul cruscotto segna 96° F, oltre 35 gradi celsius. Dopo duecento miglia attraverso la pianura arida al confine con l’Arizona – con l’aria condizionata al massimo – scendere all’improvviso significa rischiare il collasso.
Nel piccolo parcheggio del 7-Eleven, apro lentamente la portiera della Focus e aspetto qualche secondo appoggiato al volante, inspirando profondamente a bocca aperta. Il caldo è talmente intenso che scotta il palato. Quando mi sento pronto, scatto fuori dall’auto per fiondarmi il più velocemente possibile all’interno del negozio a chiedere informazioni.
Baker è poco più di un crocevia per automobilisti di passaggio, qualche negozio di souvenir e un paio di motel; ma è piuttosto trafficata perché vi si incrociano la SR-127, che proseguendo a nord per circa 40 miglia porta dritti nell’inferno della Death Valley, e Kelbaker Road, la porta sull’inquietante Mojave National Preserve, un deserto arido e arso dal sole a una settantina di miglia da Las Vegas. E’ proprio qui che sono diretto.
Ci sono già passato in un viaggio precedente: ricordo colline di sabbia simili a cumuli di cenere di sigaretta che mi diedero l’impressione di essere in un gigantesco portacenere. Il Mojave è un deserto per davvero, sterminato e pauroso; messo qui per un motivo. Sfidare l’incauto viaggiatore e giudicare se è degno di entrare nella florida California.
Ho intenzione di accettare la sua sfida: dormirò all’interno della riserva per assaporare in piena solitudine la notte di Luna Piena. Non ho con me un ricovero notturno, a parte l’auto a noleggio e il sacco a pelo, ma il Nippeno Camp – basici tepee indiani con corpo in lamiera e tetto in tela cerata – può fare al caso mio. Il proprietario mi avvisa che il campeggio è chiuso da qualche settimana per una serie di “importanti ristrutturazioni“ in attesa dell’estate, ma è disposto a far dormire un vagabondo italiano con poche pretese, a patto di presentarmi direttamente a casa sua a Baker per ritirare chiave e mappa. Per questo ho dovuto allungare la strada di qualche miglio ad ovest per raggiungere questa specie di paese fantasma. Prendo due galloni d’acqua – uno per me e uno per il motore della Ford – un paio di sandwich e un po’ di frutta e mi avvicino alla cassa.
La cassiera è molto giovane e piuttosto carina. Ha un fermaglio per capelli molto vistoso a forma di antilope.
Le chiedo se conosce Tom, il proprietario del Nippeno Camp e lei allarga un sorriso. Inizia a parlare ma proprio in quel momento dalla Death Valley Road arriva un gruppo di motociclisti e il rumore dei motori copre completamente la sua voce. Le chiedo gentilmente di ripetere.
“Si, lo trova proseguendo a sinistra per tre, quattrocento metri. La sua casa è ad un solo piano di colore giallo. Non può sbagliare.”
La ringrazio, aggiungo alla mia spesa un paio di barrette di cereali e una birra ghiacciata, e pago. Proprio mentre esco dal negozio almeno sei Harley Davidson stanno spegnendo i motori nel parcheggio.
Trovo subito la casa di Dixie, ma non sembra esserci nessuno. Ben piantato al centro della porta, fermato con una puntina, c’è un foglio di carta scritto a mano e un pezzetto di spago che termina in una chiave. Decisamente efficiente. Stacco la chiave, do un occhiata alla mappa e mi dirigo verso la solitudine del campeggio. Ho fretta di arrivare prima del tramonto: adoro vedere il sole abbassarsi dietro le dune di sabbia, magari comodo nella veranda sorseggiando la mia birra ghiacciata. Mi sembra un progetto fantastico.
Appena superato Nipton trovo sulla destra la Desert Road, e il segnale di ingresso nel Deserto del Mojave. Mi inoltro per qualche miglio e dopo aver sorpassato una ferrovia in disuso vedo in lontananza alcune strutture inconfondibili, è la parte superiore delle tende del campeggio. Il tutto è completato da un edificio che dovrebbe essere l’hotel ma pare alquanto in disuso e un negozio di chincaglierie – ovviamente chiusi. Il vento alza mulinelli di sabbia creando uno scenario da film western. La tenda numero 9 è la più lontana, sul fondo della piccola vallata dove circondata da Joshua Tree.
Più che tepee si tratta di una palafitta rialzata da terra di almeno mezzo metro, con una piccola entrata a cui si accede da una scaletta. Entro in un nugolo di zanzare e insetti. E’ il posto più fottutamente caldo in cui sia mai entrato. I comfort consistono in una brandina con un materasso senza lenzuola, una piccola lampada ad olio, un ventilatore ed una gigantesca stufa. Dovrò rinunciare al mio progetto di birra più tramonto in veranda, perché non ce l’ho, la veranda.
A questo punto resta solo da capire dov’è il bagno: non che sia molto importante avendo ettari di arida terra a disposizione, ma la curiosità dell’esplorazione mi obbliga a muovermi. Trovo il bagno tra la tende 3 e 4, talmente lontano dalla mia che necessiterei ogni volta della macchina per andarci a pisciare, cosa che non farò. Anche perché, mentre giro intorno ad una parete di lamiera, un serpentaccio lungo più di un metro scatta furioso nella mia direzione. Comprendo perché i tepee sono rialzate.
Ritorno di buon passo verso il mio alloggio, augurandomi che oltre ad essere rialzato da terra sia anche sigillato a dovere.
E’ quasi il tramonto: in lontananza il sole tinge la dune di sabbia di una tonalità di rosa mai vista. Fa ancora molto caldo, e l’arsura in gola mi fa ricordare della birra ghiacciata. Oramai è appena fresca, ma è comunque deliziosa. Un centinaio di metri avanti a me, proprio in direzione delle colline di cenere un predatore notturno, un puma, sta guardando nella mia direzione. Il manto bruno è indurito dal sole e dalla sabbia. Urlo a squarciagola per sentire se c’è qualcuno nelle vicinanze ma l’unica risposta che ottengo è il sibilo del vento.
Pensavo di essere spaventato da tutto ciò: in realtà sapere di essere completamente solo, abbandonato in una terra selvaggia, senza cellulare e senza internet mi fa sentire bene. La notte profuma di saggina mentre un freddo secco spazza l’afa pomeridiana; a nord le colline di sabbia si stagliano oramai come bastioni scuri e minacciosi contro il sole calante. Ma è tutt’altro che tremenda e in quest’aria senza acqua pare quasi che le stelle scendano a darti il benvenuto. Ora il deserto non sembra fare così paura e la quiete silenziosa mi fa riflettere sull’importanza di luoghi come questo. Sento il misticismo della vita che combatte, con le sue complicate leggi, la battaglia per la sopravvivenza contro l’arsura del sole. La vita ha bisogno di acqua, e una grande organizzazione di materia sopravvive fingendosi morta sopra la terra secca e arida. Proprio come l’operoso astragalo dal fiore rosa o il serpente a sonagli che ha tentato di aggredirmi poco fa, nascosto nell’ombra di un pezzo di canvass abbandonato. Le giornate sono lunghe e solitarie, sferzate dal sole. Ma la notte il deserto brulica di attività e un universo di creature si desta e contribuisce alla formazione di un complesso ecosistema. Gli alberi di Yucca diventano scale preziose per i giochi divertiti degli scoiattoli di terra mentre i cactus della California, ricchi di acqua immagazzinata durante le rare piogge, offrono rifugio a tarantole e lucertole. Numerose specie diventano prede di cacciatori più grandi, come la lince rossa o la piccola volpe del deserto.
Do una ultima occhiata al giorno che si spegne e rientro sotto la tenda accendendo il rumoroso ventilatore centrale. Sono oramai completamente rilassato quando un rombo di tuono mi riporta all’improvviso alla realtà. Il rumore continua ad avvicinarsi e non può essere il tuono, sembra piuttosto il rumore di un motore.
O meglio, di cento motori messi tutti insieme. Che diavolo sta succedendo là fuori?
Esco timoroso sulla scaletta esterna e vedo, in lontananza, decine di luci venire nella mia direzione. Non so perché, ma vengo assalito da una paura primordiale. Spengo la lampada e corro un centinaio di passi fino alla cabina 10, che mi permette di guardare verso occidente senza essere visto. Un brivido di terrore mi corre lungo la schiena: sono i motociclisti che avevo incrociato qualche ora prima. Che ci fanno qua? Il campeggio è chiuso e non c’erano altre chiavi sulla porta. In ogni caso meglio non farsi vedere. Non si sa mai.
Il rombo continua ad avvicinarsi e comincio a vedere i fanali delle moto attraverso la tenda superiore. Sono intorno al mio tepee e continuano a girare in cerchio, il rumore è assordante. All’improvviso, quasi all’unisono, tutto si ferma. Ora è chiaro, sono qui per me. Come un condannato alla pena di morte che aspetta l’ora dell’esecuzione, attendo l’assalto. Il senso del tempo è estremamente dilatato, passa un eternità.
Ancora silenzio.
Poi, a sorpresa, sento una voce di donna alle mie spalle. E’ difficile tradurre esattamente da un inglese sbiascicato ma più o meno le parole sono:
“Ehi ometto, ma sei tutto solo li dentro?”
Non rispondere, mi dico. Non rispondere. Stai dormendo, non hai sentito nulla.
Ma ora sento numerose voci intorno alla mia tenda. Cazzo, ma quanti sono?
Incominciano a bussare alla porta. Tutti quei film horror che ho visto su ignari studenti americani che finiscono inconsapevolmente nel posto sbagliato allora non sono fantasia, succedono veramente queste cose. Non posso più fare finta di niente: meglio aprire e inventare qualche storia in grado di evitarmi guai. Mi sono già trovato un paio di volte in situazioni difficili e me la sono sempre cavata, ce la farò anche questa volta.
Apro la porta.
Un orso ricoperto di pelle nera entra nella stanza senza indugiare in convenevoli. E’ più alto di me e pesa tre volte tanto. Ha una bandana sulla testa e un tatuaggio sul collo, sembra un teschio alato. Dopo di lui entra una donna, sui quaranta, capelli biondi e una benda a coprire un occhio. Con orrore mi accorgo che ha tra le mani un fermaglio a forma di antilope: è proprio il fermaglio della cassiera del 7 Eleven. Cazzo.
L’uscita è bloccata da un terzo uomo, magro e con lunghi baffi bianchi. Gli altri sono rimasti sulla sella delle moto. Sono otto, dieci in tutto. Il capo si guarda un po’ intorno e nota sul letto il mio computer acceso. Di tutte le cose che avrebbe potuto dirmi prima di farmi molto male, quella che pronuncia è piuttosto sorprendente:
“Hai dei film porno lì dentro?”
La donna sui quaranta gli risponde con una risata roca e dice:
“Non ne abbiamo bisogno. Siamo venuti qua proprio per farci il nostro, di porno. Lo faremo qua dentro, e tu parteciperai.”
Nel pronunciare queste parole, mi si avvicina e mi strizza il sedere con una mano soffiandomi il fumo della sigaretta in faccia. Altre due donne (o uomini con i capelli lunghi) scendono dalle moto e si avvicinano all’entrata. Le cose si mettono veramente male.
“Dove hai preso quel fermaglio?” è l’unica cosa che mi viene in mente di chiedere.
“Ah, questo? Oggi abbiamo fatto un gioco con la cassiera. Le è piaciuto molto.”
La spingo con forza contro il ciccione e mi butto con tutta la violenza possibile verso la porta, deciso ad uscire in qualche modo. In pochi secondi succede il finimondo: lo spilungone baffuto si sposta per lasciarmi passare, ma nell’affrontare il primo gradino inciampo e sto per franare faccia a terra.
A questo punto una delle due ragazze scese dalla moto si lancia come per placcarmi ma è troppo tardi e rotoliamo entrambi sulla sabbia. Cado sopra di lei che mi fa scudo col corpo. Stretti in un abbraccio, mi rendo conto che la lei è un lui capellone. Sto per rialzarmi e scappare quando l’altra persona mi porge una mano e mi fa:
“Ehi amico, tutto ok?”
Alzo lo sguardo e di fronte a me, con un paio di jeans attillati e una camicetta rosa c’è la cassiera del 7 Eleven. Ma, allora? Che succede? Dolcemente mi porge una mano per rialzarmi e, appena sono in piedi, mi abbraccia.
“Stavamo solo scherzando. Mi chiamo Jenny, e quella con la benda è mia sorella Rose. Vive a San Francisco. E’ in giro per una settimana on the road con alcuni amici ed è passata a salutarmi, non la vedevo da quasi un anno.”
La sorella di Jenny si toglie la benda dall’occhio e mi porge una mano.
“Oggi quando mi hai raccontato che saresti venuto qua tutto solo mi è venuto in mente di farti uno scherzo, tutto qua. Ma, stai tremando?”
Già, vorrei dirle, sto tremando. Con tutto il rispetto, cara Jenny, bello scherzo di merda.
Alla fine, scendono tutti dalle moto e tirano fuori da un frigo portatile lattine di birra e una bottiglia di whisky. Il bestione si chiama Rocky ed è il marito di Rose. Non tirava fuori la moto da mesi. “E soprattutto non mettevo questa roba da dieci anni. Devo essermi ingrassato un po” mi dice mentre la moglie gli allunga un colpetto nei reni.
Parlo a lungo con Jenny, mentre il mio cuore rallenta e il respiro torna regolare, e con il fidanzato capellone, che si è fatto un piccolo taglio su un avambraccio per evitare che mi facessi male.
Le lattine di birra si vuotano in breve tempo, e mentre la notte si riempie di stelle sopra la nostra testa, a bassa voce Rocky mi sussurra:
“Ma ce l’hai davvero quel film porno da passarmi?”
In lontananza quattro piccole sfere luminose si aggiungono alla platea di osservazione: due puma si godono lo spettacolo prima di cominciare l’ennesima battaglia per la vita, uguale alla precedente e alle mille altre che in seguito verranno.